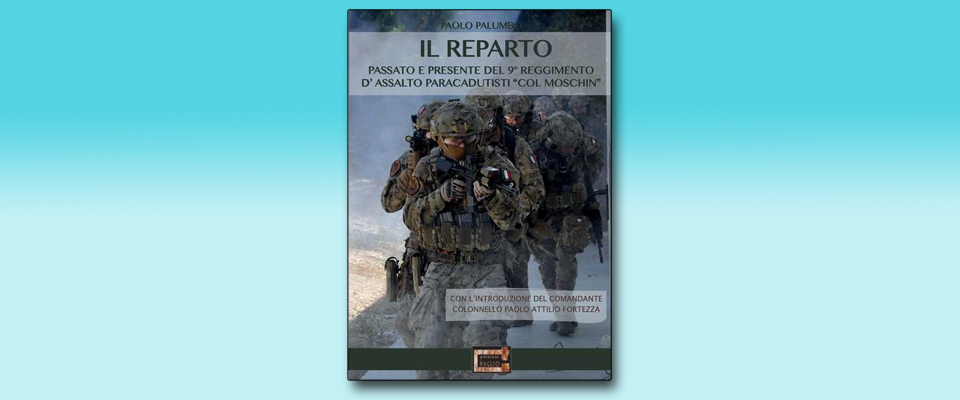
Italiani valorosi/ “Il Reparto”, la storia del IX° Col Moschin
Home livello 2 - di Marco Valle - 28 Febbraio 2017 alle 12:08
Incredibilmente, in quest’Italia stanca, cialtrona e disincantata alcune eccellenze esistono e resistono. Nella ricerca scientifica, nell’industria, nell’arte. Piccole isole di grande energia e valore (giustamente) esaltate dai mass media. Ma non vi sono solo scienziati, ingegneri, creativi, artisti; disperso nei luoghi meno felici del globo opera, lavora, combatte un piccolo mondo militare di cui, invece, si parla e si scrive poco, pochissimo. È la sorte delle nostre unità d’élite, realtà formidabili quanto misconosciute, eppure rispettate, stimate dagli alleati (non sempre molto cordiali) e temute dai nemici (sempre ostili).
Nulla di strano. I soldati, quelli veri e seri, sono fastidiosi, ingombranti e, come avverte il generale Marco Bertolini, quando la povera politica italiana è costretta a ricorrere a loro (il mondo, si sà, è turbolento…) « si procede alla produzione di dense cortine fumogene per occultare, dietro un fitto velo di richiami alla pulsione umanitaria italiana, alla nostra atavica bontà d’animo, alla nostra “meravigliosa” costituzione, ad una nostra supposta avversione alla violenza e così via, una realtà internazionale che non le aggrada».
Da qui le fiabe rassicuranti sulle missioni di “pace”, con i fanti sorridenti che distribuiscono caramelle e giocattoli ai bimbi di terre lontane. Purtroppo il pieneta non è un kindergarten e neppure un parco giochi e le forze armate hanno altri doveri e altri compiti, ben più duri e impegnativi. Bisogna combattere, sparare, uccidere o venire uccisi. È la guerra, l’eterna “festa crudele”.
Per capire, comprendere motivazioni, ragioni, ideali di chi sceglie, anche in questo tempo post-eroico, di “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” è arrivato ora il bel libro “Il Reparto”, di Paolo Palumbo, dedicato al Nono “Col Moschin”, il ferro di lancia dell’esercito italiano. Con minuzia e precisione l’autore ricostruisce la lunga vicenda dei reparti d’assalto, a partire dalla prima guerra mondiale con la formazione, nell’estate del 1917, degli arditi. Tra tutti il IX° reparto d’assalto, comandato dall’allora maggiore Giovanni Messe, un ufficiale fuori dall’ordinario: un uomo coraggioso, intelligente, carismatico. Grazie a lui , nel 1918, le “fiamme nere” dimostrarono tutto il loro valore nella conquista dello strategico Col Moschin. Fu allora che la leggenda cominciò.
Ma andiamo per ordine. All’indomani della vittoria, i reparti degli arditi — per motivazioni politiche ma anche economiche, i governanti d’ogni colore sono sempre taccagni quando si parla di difesa… — vennero sciolti e un patrimonio di esperienze si dissolse. Nei vent’anni seguenti, nonostante la fragorosa retorica militarista del regime fascista, per lungo tempo si preferì dimenticare le dure lezioni delle tempeste d’acciaio della “grande guerra” e non si parlò più di reparti speciali, di impieghi e tattiche innovative, moderne, “non convenzionali”. Un ritorno all’Ottocento, alla “normalità”. Solo Italo Balbo, uomo intelligente e anticonformista, cercò di costituire una prima unità di “fanti dell’aria” — per lo più volontari libici — a Castelbenito in Libia. Poco, troppo poco per affrontare la nuova, terribile tempesta bellica.
Come spiega Palumbo, soltanto nel 1942 — quando l’Asse italo-germanico iniziò a vacillare — lo Stato Maggiore decise finalmente di formare, affidandola al colonnello Renzo Gazzaniga — un’unità scelta di paracadutisti-sabotatori, il X° Reggimento Arditi. Troppo tardi. Nonostante gli sforzi e la dedizione dei volontari, mezzi, pianificazione e logistica si rivelarono drammaticamente insufficienti contro un nemico sempre più potente e ben organizzato. Da qui le meravigliose quanto disperate imprese del Decimo in Tunisia, in Algeria e, poi, in Sicilia e in Calabria. Infine l’8 settembre, l’armistizio. Una data amara e lacerante.
In quel terribile intrico di sentimenti contrastanti — un impasto di fedeltà intrecciate, delusioni e smarrimenti — gli arditi del Decimo si divisero. Alcuni scelsero di seguire il comandante Boschetti e, con i resti del Regio esercito, combatterono nella lunga campagna d’Italia; altri decisero di continuare la guerra con il mai amato alleato tedesco e, sotto il comando del colonnello Marcianò, continuarono a guerreggiare in Russia, in Francia, in Italia. Con la RSI. Con Mussolini. Sino alla fine.
Nel 1947 i nuovi equilibri internazionali del secondo dopoguerra, il fissarsi della “cortina di ferro” nel cuore dell’Europa e l’inizio della guerra fredda tra Occidente e Unione Sovietica, offrirono all’Italia vinta e lacerata una nuova, inattesa possibilità. Nonostante il penalizzante trattato di pace di Parigi, presto su pressione USA ammorbidito (con gran dispiacere dei britannici e dei francesi ed enorme fastidio dei sovietici), il Patrio Stivale tornò, per quanto acciaccato, sullo scenario internazionale.
Come è noto — si leggano le ricerche di Di Nolfo, De Leonardis, Ilari, Romano, Di Rienzo — dopo il 18 aprile 1948, una volta defenestrato il PCI dal governo, il premier democristiano Alcide De Gasperi comprese che per contare qualcosa sul tavolo da gioco a Roma serviva una struttura militare credibile. Da qui il parziale riarmo italiano, una distratta (ma sostanziale) attenzione alle cose militari e il successivo approdo all’interno della NATO. Un punto di svolta.
In questo contesto le nuove forze armate nazionali vennero ricostruite e riarmate. Al tempo stesso, con molta fatica, s’iniziò a ragionare sulle esperienze delle unità speciali: a partire dagli anni ’50, nonostante le diffidenze del mondo politico, nacque il primo reparto paracadustisti e poi, dal 1952, un “plotone speciale” di nuovi arditi. Il tutto grazie all’iniziativa di un giovane tenente, Franco Falcone, e l’aiuto di un marinaio d’eccezione: Gino Birindelli, l’eroe di Gibilterra. Tentativi pioneristici da cui prese forma a Cesano la Compagnia Sabotatori Paracadutisti, affidata ad un valoroso reduce di El Alamein, il capitano Acconci. Poi, nel 1961, Livorno, la “Vannucci” e la formazione del Battaglione Sabotatori Paracadutisti, un vero e proprio laboratorio dottrinale in cui s’intrecciarono le esperienze dell’arditismo italiano con le lezioni francesi, inglesi ed americane sulla “guerra rivoluzionaria”, un’altra dimensione.
Grazie ad ufficiali d’eccezione come Domenico Solinas, Valdimiro Rossi (chi scrive ebbe l’onore di servire sotto il suo comando a Pisa nei primi Ottanta) e Franco Angioni, il reparto raggiunse presto livelli d’eccellenza. Il primo banco di prova fu la “guerra segreta” in Alto Adige contro i terroristi austriacanti: uno scenario difficile, simile per molti aspetti all’Algeria dei francesi e all’Ulster dei britannici. Fu una pagina sanguinosa e (guarda caso…) cancellata dalla nostra storia ufficiale, come gran parte della lotta dello Stato — e delle forze speciali — contro l’eversione rossa e internazionale negli anni Settanta.
Poi la svolta. Nel 1981, il governo — su impulso di Bettino Craxi, politico discutibile ma uomo lungimirante — decise di avere, per una volta, coraggio. Tra mille polemiche, Roma inviò un contingente nel Libano sconvolto dalla guerra civile. Per la prima volta dalla sconfitta, l’Italia dava un segnale forte di presenza nel Mediterraneo. Con i suoi soldati, i ragazzi di leva e i pochi, allora, professionisti. Gli incursori del Nono, ovviamente, furono in prima linea.
Da qui la storia è nota, conosciuta: dopo il Libano, la Somalia, l’Africa equatoriale, l’Iraq, i Balcani, l’Afghanistan, la TF 45 e oggi la Libia. È la storia del “Col Moschin”. Le tante venture e il molto sangue versato del Nono. Una bella, importante storia che Paolo Palumbo racconta senza retorica e senza fronzoli. Con serietà e discreta scrittura. Insomma, un ottimo lavoro che avrebbe meritato una veste grafica più elegante e una cura editoriale (troppi refusi, nessuna lista di nomi etc…) meno artigianale, meno improvvisata.
Confidiamo nella seconda edizione. In ogni caso, buona lettura. Il libro merita.
Paolo Palumbo – IL REPARTO – Edizioni il Maglio, 2016 – Ppgg. 273, euro 28.00
di Marco Valle



