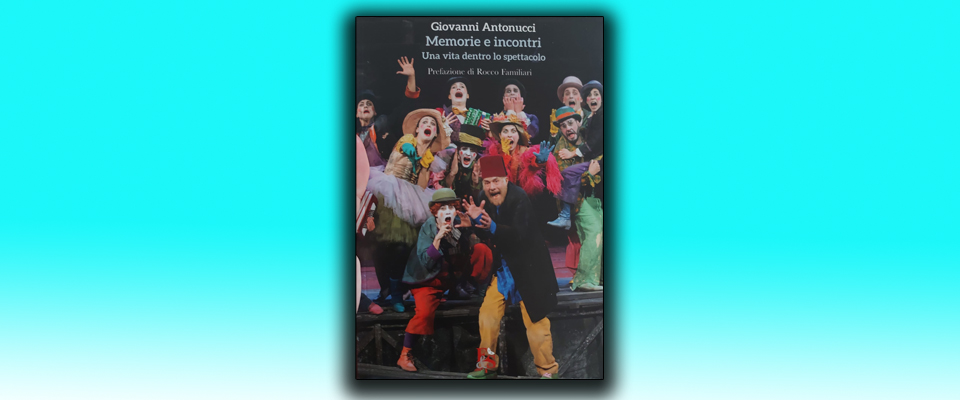
Memorie e incontri (memorabili…) di Giovanni Antenucci: uno specchio sulla società e sulla sua vita
Günther Anders, uno dei maggiori filosofi dell’era “postatomica”, pensatore anticonvenzionale e realmente impegnato[1], sostiene che questa è l’ultima epoca della storia, perché c’è una circostanza che ormai non potrà più cambiare, e cioè il fatto che l’uomo è in grado di distruggere, con il mondo in cui ancora vive, la storia stessa. Che è, val la pena ricordarlo, prerogativa esclusiva degli uomini. E mai come in questo momento, con una feroce guerra nel cuore dell’Europa e la minaccia, più volte ripetuta, di usare l’arma finale, l’amara deduzione di Anders appare in tutta la sua drammatica veridicità.
C’è un altro elemento che caratterizza però questa epoca, ed è che presto scomparirà la memoria. Può sembrare paradossale un’affermazione del genere, proprio quando si dispone di apparecchiature sempre più potenti che registrano ogni attimo dell’esistenza, mettendolo a disposizione di chiunque. Ma è per questo che la memoria, quella individuale e perciò con essa anche quella collettiva, sparirà. L’uomo ormai delega i suoi ricordi al pc o allo smartphone, con ciò privandosene. Mentre si illude di conservarli, tutti e per sempre, è vero il contrario: la loro mole costituisce la loro perfetta inutilità. In un mio testo andato in scena nel ’93 al Teatro Valle di Roma (Il Presidente, con Raf Vallone e la regia di K. Zanussi), il protagonista, un magnate dell’informazione, conserva nei suoi immensi data-base ogni momento della sua vita e di quelle altrui, ma a un certo punto è costretto ad ammettere che “solo Dio ha il tempo di rivedere tutto quello che è accaduto”. L’autocitazione vuole soltanto sottolineare come la problematica mi interessi, rectius, mi angusti, da tanto tempo.
Tutto questo comporta due conseguenze di pari gravità: la perdita di consistenza – l’uomo è ciò che sa e quindi ciò che ricorda, o per citare le Memorie di un amnesiaco (apparente ossimoro) di Satie, “il passato serve ad armarsi solidamente” – e l’impossibilità di trasmettere esperienze, emozioni, un patrimonio di esperienze non sostituibili dalle informazioni circolanti sulla rete (troppe, secondo Eco, che sottolineava la difficoltà, senza adeguati punti di riferimento, vale a dire una cultura di base, di orientarsi in una tale ridondanza, o come la definiva brutalmente Carmelo Bene, “immondezzaio universale”).
Corollario inevitabile, secondario se si vuole, ma fino a un certo punto, è che sparirà il genere della memorialistica, a cominciare dalla parola stessa, che forse è già scomparsa dal lessico. Quelli della mia generazione, che poi è la stessa dell’autore di questo prezioso libro, si sono nutriti di “memorie”, da quelle classiche (cosa sono le Confessioni di Sant’Agostino se non memorie?) a quelle più recenti. Non c’era biblioteca di professionista (allora una classe colta per definizione, al contrario di quanto accade oggi, in cui la maggior parte dei suoi esponenti, spesso sa tutto di una piccola porzione dell’ambito specialistico di pertinenza, ma nulla di tutto il resto) in cui non facesse bella mostra di sé il Memoriale di Sant’Elena di Napoleone, e, dopo le due grandi guerre (ma perché continuare a chiamare così i due conflitti mondiali? è un aggettivo fuorviante, non hanno nulla di grande, sono state soltanto delle carneficine senza senso), il profluvio di ricordi, memorie, autodifese, j’accuse, di feldmarescialli o semplici marescialli, ammiragli, capi di stato, comandanti di sommergibili o di campi di prigionia, a volte anche con pregi letterari (la Storia della Seconda Guerra Mondiale di Churchill, cioè le sue personali memorie dell’evento, gli valse il Nobel) altre meno, ma con la pretesa di fornire un punto di vista originale e veritiero (?!), ha costituito, in assenza dei social, un’efficace controinformazione alla ricostruzione storica, per lo più fatta, ça va sans dire, dai vincitori.
Una lunga premessa per affermare, con una certa dose di rammarico, che queste Memorie e incontri di Giovanni Antonucci, sono probabilmente fra le ultime che vedranno la luce. E dobbiamo essergli grati per avere, in una tale felice stagione della sua esistenza – una seconda o terza o quarta giovinezza, in cui ha già pubblicato tre straordinarie, per ampiezza e interesse, raccolte di aforismi – realizzato per i lettori, soprattutto amanti del teatro, ma non soltanto, un mirabile affresco, dettagliatissimo, sulle vicende dello spettacolo italiano degli ultimi sessant’anni. Egli è stato infatti, protagonista o testimone diretto di tutto ciò che di significativo è accaduto in quel mondo, sia nella sua veste di docente di Storia del Teatro, sia di realizzatore di memorabili (torna il termine…) spettacoli radiofonici o televisivi, sia di autore di originali e molto apprezzati, dalla critica e dagli spettatori, lavori per la scena. Ed è incredibile la quantità di notizie, riferimenti, collegamenti, che riesce a fornire, pescando soltanto in quello che Voltaire definiva il “magazzino della memoria” (fonte, a suo dire, delle idee), un magazzino, va riconosciuto con stupore, di incredibile capienza. E’ anche, se si vuole, una storia della seconda metà del secolo scorso, descritta secondo un’ottica particolarmente sofisticata, vale a dire la riflessione che gli operatori culturali, per usare un termine onnicomprensivo, hanno fatto, con le loro opere, sullo stesso periodo di tempo. Diventa, questo suo, ripeto, prezioso volume, uno specchio, non passivo, ma, se si può dire così, intelligente, di una società, dei suoi problemi, delle sue ansie, molte, delle sue gioie, anch’esse tante, dei suoi ideali o sogni. E con uno stile che si potrebbe definire una sorta di “presa diretta”. Da qui la particolare vivacità della scrittura e la sua capacità di catturare il lettore che spesso si sente soffocato – è accaduto anche a me – dalla quantità prodigiosa di avvenimenti ricordati, ma dopo qualche attimo di smarrimento ci si rende conto della ricchezza e generosità del dono ricevuto e si procede In quello che è un autentico “viaggio”.
In trentuno, densissimi, capitoli, l’autore, consapevole, come egli stesso afferma, che “i libri di memorie scontano il rischio dell’autoreferenzialità”, ma “sono anche” – aggiunge – “una riscoperta della propria attività”, ripercorre la sua lunga vita, rievocando fatti e personaggi che hanno segnato il suo tempo. Va ricordato, per dare un’idea dell’ampiezza della ricognizione, e l’elenco non è certamente esaustivo dei suoi molteplici interessi, che Antonucci è autore, per citarne solo alcuni, di fondamentali studi sul Futurismo, curatore, per Newton Compton, delle opere di Ibsen, è stato anche critico militante per importanti testate nazionali, ha pubblicato una informatissima, e pregevole per serenità di giudizio, Storia del Teatro italiano contemporaneo (pubblicata, in più edizioni, da Studium), fine musicologo e appassionato di arte figurativa (i suoi interventi nel campo li ha fortunatamente raccolti in un volume, Da Manet a Wharol, edito nel 2013), traduttore e adattatore di una trentina di commedie del teatro antico e moderno, Producer di un centinaio di programmi televisivi di fiction, prosa e rubriche culturali, curatore del programma “Il libro, un amico”, primatista di audience nel suo genere con quasi quattro milioni di telespettatori, Presidente (o componente) di giuria di una infinità di premi letterari, da ultimo, come ho ricordato più sopra, autore di una formidabile trilogia di Aforismi, genere che gli è particolarmente congeniale, data la vivacità del suo intelletto, quello che nella Introduzione al più recente dei tre volumi, intitolato Vizi (molti, Virtù (poche), edito da Universitalia nel 2022, ho definito lo “‘stile Antonucci’, un mix di intelligenza vivacissima, cultura raffinata ed eleganza di tratto”, definizione nella quale egli, senza falsa umiltà, si riconosce pienamente, se ha voluto riportarla nella chiusa di questo ultimo (per ora) libro.
Accanto alle “Memorie”, vi sono gli “Incontri”, e giustamente l’autore ha voluto sottolinearne l’importanza. Ha infatti avuto modo, per dovere professionale, ma anche per semplice curiosità intellettuale, di incontrare tutti i grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana e non solo, rendendone testimonianza in interviste pubblicate su giornali o riviste e ora qui raccolte (alcune sono state riproposte sulla, ormai imprescindibile, rivista “Teatro Contemporaneo e Cinema”, diretta da Gianfranco Bartalotta). Fra i personaggi più importanti, certamente Peter Brook, Marcel Marceau, Bob Wilson e soprattutto il polacco Tadeusz Kantor, pittore di notevole talento e regista straordinario. E da questa “sezione” emerge, ancora una volta, la sua duttilità mentale, la freschezza dell’approccio, assolutamente libero da pregiudizi o da timore reverenziale (che in qualche caso sarebbe stato più che giustificato). Il genere dell’intervista è fra i più difficili che vi siano, ed è abbastanza anomalo che spesso a pubblicisti alle prime armi venga affidato il compito di intervistare celebri personaggi, dello spettacolo o della cronaca, con esiti a volte decisamente imbarazzanti. I grandi intervistatori sono rari e tutti, quale che sia la loro connotazione politica o ideologica, universalmente riconosciuti come maestri, da Montanelli a Biagi, alla Fallaci, per ricordare i più noti. Occorre infatti, non soltanto cultura, generale e specifica, riguardante cioè il contesto in cui agisce l’intervistato, ma anche intuito, prontezza di riflessi, empatia, capacità di portare l’interlocutore più schivo o restio sul punto che interessa, autodisciplina, per evitare di sovrapporre il proprio punto di vista a quello dell’altro, doti di narratore. Antonucci appartiene a questa razza e lo dimostra ampiamente negli “Incontri” di cui dà contezza. Riporto soltanto, per stimolare l’interesse del lettore, qualche passo riguardanti tre incontri che egli definisce fondamentali e che danno l’idea della sua abilità, ma anche del suo coinvolgimento emotivo e intellettuale, quelli con Peter Brook, Marcel Marceau e con l’autore de La classe morta e di Wielopole Wielopole, quel Tadeusz Kantor a cui si devono alcune fra le realizzazioni più importanti della storia del teatro moderno.
“Brook, che ci ha lasciati alla veneranda età di 97 anni, è stato il più geniale e colto regista della seconda metà del Novecento, il creatore di un teatro dello “spazio vuoto”, titolo di un suo famoso libro. In un’epoca dominata dal ruolo crescente della scenografia, da quella neobarocca a quella astratta, Brook ha creato spettacoli memorabili senza praticamente scene, tutti giocati sul rapporto fra il testo e la recitazione. Si definiva con umiltà “un suggeritore” dei suoi attori, ma nessuno come lui era maestro nello scoprirli e nel guidarli verso esiti altissimi. … Conobbi Brook in occasione di un suo spettacolo emozionante, La conférence des oiseaux, tratto da un testo persiano del Medioevo. … Andai da lui in pieno pomeriggio, in uno spazio teatrale romano, un poco di fortuna, e lo trovai a dirigere una prova dello spettacolo che avevo visto la sera precedente. Una rarità da noi, come la sua cordialità nell’accogliere una persona che non conosceva. Con mio stupore interruppe la prova, diede mezz’ora di pausa, che poi diventò un quarto d’ora in più, e accettò con umiltà di dialogare con un giovane critico. Mi colpirono subito, oltre al suo fluido ed elegante francese con cui parlammo, il suo viso sereno di gentiluomo inglese, allora di mezza età, i capelli candidi, il colorito roseo, gli occhi azzurri ingenui e insieme leggermente ironici che lo rendevano assomigliante in qualche maniera a Charlie Chaplin.”
Con pochi tratti, di magistrale sobrietà e allo stesso tempo finezza descrittiva, riesce a dare un’immagine viva del personaggio, della sua importanza nel mondo dello spettacolo, ma anche del suo lato umano. La conversazione toccò poi alcune delle realizzazioni più importanti del grande regista, dal Mahabharata, all’Ubu Roi di Jarry, a proposito del quale Antonucci rileva acutamente che:
“Brook si era posto di fronte ai due testi di Jarry in una posizione di umiltà intellettuale e artistica. Che cosa erano Ubu re e Ubu incatenato se non, come voleva lo stesso autore, due farse goliardiche, concepite da un liceale per deformare uno dei suoi insegnanti che per lui rappresentava il massimo di grottesco che potesse esistere al mondo? Mére Ubu è per Brook un personaggio tra la portinaia, la rigattiera e la custode di gabinetti. Erano due straordinarie farse di collegio, con una irresistibile parodia dell’Amleto, che creavano situazioni assurde e grottesche, ben diverse da una tradizione interpretativa che le aveva caricate di significati ideologici e di sofisticati simbolismi.” Di Marceau, ancora una volta, il fine “disegnatore” Antonucci, restituisce, in poche, essenziali frasi un ritratto completo, del “mito della pantomina”, come lo definisce, del Personaggio e dell’Uomo.
“Ero rimasto incantato dal suo personaggio, Bip, nipote di Pierrot, con il cilindro sul quale si innalza un fiore rosso, la maglietta a righe e i pantaloni bianchi da acrobata, la faccia di biacca, l’occhio di carboncino circonflesso e la bocca rossa, sottile come una lama. Bip rappresentava l’innocenza e la libertà dell’uomo di fronte alle mille schiavitù che lo insidiano. Dalla prima volta che lo avevo visto sul palcoscenico mi era venuto il desiderio di scoprire chi era Marceau dietro la maschera di Bip … Al primo momento, non lo riconobbi e non avrei potuto riconoscerlo, dato che l’avevo visto solo in scena nelle vesti di Bip. Poi ho immaginato che fosse lui quel signore di mezza età, vestito come un medico o un ingegnere, che mi veniva incontro pur non conoscendomi. … Rimasi colpito dalla brillantezza del suo eloquio, dal suo spirito e dalla sua cordialità. Gli raccontai delle volte che lo avevo visto sul palcoscenico, della grande impressione che mi aveva fatto il suo Bip, della poesia dei suoi spettacoli. Marceau parlava con un’eleganza e con una lucidità che mi colpì. Il discorso era accompagnato dalla straordinaria espressività delle mani che davano più forza alle sue parole. Gli chiesi che rapporto c’era fra lui e Bip. A prima vista, Marcel mi sembrava molto diverso. Mi sorrise e replicò prontamente: “Non c’è alcuna differenza fra me e lui. Bip è la mia vita, la mia realtà, la realizzazione delle mie aspirazioni. Non credo alla possibilità di una scissione fra l’uomo e l’artista”.
Infine Tadeusz Kantor, il grande regista e autore polacco fondatore del mitico Teatro Cricot 2 di Cracovia.
“Questo grande artista parlava un francese fluido e così non ebbi alcun problema linguistico da superare. Fu disponibile e aperto nel raccontarmi la nascita a Cracovia del Teatro Cricot 2, quali erano i suoi principi, il ruolo dei due Manifesti da lui stesso scritti, Il Manifesto degli imballaggi e Il Manifesto del Teatro zero, l’importanza di Witkiewicz: ‘Il Teatro Cricot 2 è un tentativo di creare una sfera di comportamento artistico libero e gratuito in cui ogni linea di demarcazione convenzionale è soppressa. L’artista non trasforma la realtà quotidiana, la prende semplicemente e l’abbraccia. Egli stesso si trasforma in questo processo, mutando di conduzione e di funzione, diventando volta a volta e nello stesso tempo vincitore e vittima’ … Rividi Kantor quando mise in scena Le bellocce e i cercopitechi, sempre di Witkiewicz , spettacolo che confermò il suo originale talento. Poi con La classe morta e con Wielopole Wielopole si impose come un protagonista della scena mondiale. Il successo internazionale non lo aveva cambiato, era sempre l’artista puro di quando l’avevo conosciuto nel 1969. I suoi spettacoli lasciavano negli spettatori impressioni sconvolgenti, emozioni insolite, ricordi indelebili. Era un artista completo, regista, autore, maestro dei suoi straordinari attori, e insieme un pittore e uno scenografo, che aveva percorso con rigore assoluto le esperienze più illuminanti dell’arte contemporanea … Ebbi occasione di intervistarlo nel febbraio del 1981 … dopo che alcuni nostri giornali avevano attaccato Wielopole Wielopole per i suoi costi eccessivi … Kantor mi ricevette con la sua cordialità e con la sua simpatia umana nell’hotel che lo ospitava a Roma in occasione delle rappresentazioni trionfali di Wielopole Wielopole. Ci conoscevamo dal 1969 e mi trattò come un vecchio amico” … Morì improvvisamente a Tolosa nel 1991, dopo aver messo in scena un nuovo spettacolo, Oggi è il mio compleanno. Undici anni dopo, Firenze gli rese omaggio con una splendida mostra, Tadeusz Kantor, disegni, dipinti, teatro, che rivelò il suo originale ed eclettico talento. Scrissi un lungo articolo su “Il Giornale”, che si concludeva così: “Il Teatro della Morte di Kantor fa di lui il più originale creatore della scena mondiale. Un teatro dove manichini, oggetti e attori in carne e ossa esprimono il sentimento potente della morte che la nostra società esorcizza con il silenzio, ma che per Kantor richiama il suo opposto: la vita. Questo grande artista ha amato la vita come pochi altri e proprio per questo non ha temuto di rappresentare nei suoi spettacoli e nei suoi quadri la sua conclusione inevitabile”. Nel 2010 a Cracovia andai a visitare il piccolo museo del Teatro Cricot 2, la cui compagnia si era sciolta dopo la scomparsa del suo creatore. Nessuno in realtà poteva sostituire Kantor. Vidi qualche manichino, qualche bicicletta, qualche altro oggetto, ma erano i relitti di un’avventura artistica e umana purtroppo conclusa”.
Ho dato più spazio al suo incontro, o meglio ai suoi incontri con Kantor, perché la testimonianza riportata nel volume, che riprende quasi per intero gli articoli scritti sul regista polacco, e soprattutto l’intervista, sono esemplari della capacità di Antonucci di rendere la sostanza più autentica dell’opera dei personaggi da lui amati, con un linguaggio terso e di rara efficacia. In questo caso, nella chiusa, emerge un lato più intimo, la sua appassionata – commovente anche – partecipazione alla vicenda non solo artistica di quelli che egli considera suoi maestri.
Ma il libro non è soltanto questo. E’ anche la “memoria” di una storia personale, la sua, con ricordi a volte struggenti, soprattutto degli anni d’infanzia, dove Antonucci rivela spiccate qualità di narratore, sapiente (Auster sosteneva tempo fa in un’intervista che da un libro egli pretende sempre di imparare qualcosa e questo eliminerebbe buona parte della narrativa contemporanea…), accattivante in grado estremo. Basta l’incipit (che in altra sede[2] ho definito una “dannazione” …) a evidenziarne le doti:
“La giornata nell’isola di Lussimpiccolo era stata calda, ma la brezza che veniva dal mare l’aveva alleviata. Avevo passato tutta la giornata sulla spiaggia dorata in quell’isola istriana dove erano nati mia mamma, la nonna e gli zii. Ero un bambino con gli occhi dello stesso colore del mare e con dei capelli così biondi che gli amici della mamma mi chiamavano affettuosamente “lo svedesino”. Tutte le mattine quando la mamma mi portava in quella piccola spiaggia, che era la mia seconda casa, volevo mandare al mio papà lontano, rimasto a Roma per i suoi impegni di lavoro, una barchetta che avevo costruito con un osso di seppia. La spingevo nelle acque limpide del mare e la salutavo finché le onde non la portavano via, lontano. Avevo due anni e poco più, ma già parlavo bene e papà era la mia parola preferita dopo mamma. La tosse convulsa, che mi aveva portato così lontano dalla casa di Roma, era quasi scomparsa; il mare mi aveva guarito con il suo iodio intenso.”
Il respiro è classico, vi sono echi, e non potrebbe essere altrimenti, di opere fondamentali della nostra letteratura (delizioso il “candore” con cui ricorda la barchetta incisa in un “osso di seppia”, oggetto di cui ben conosce la potenza evocativa), il linguaggio di assoluta precisione, il tono commosso, ma contenuto (da notare l’uso di termini intimi, teneri, come “mia mamma”, “mio papà” invece che i più asettici “mia madre, mio padre”), il risultato complessivo è altamente coinvolgente.
Si tratta, voglio ribadirlo ancora una volta, di un libro importante, che andrebbe “prescritto” come testo obbligatorio nelle Accademie teatrali e nella facoltà di Discipline dello spettacolo. La conclusione dell’autore è perfettamente coerente con il suo atteggiamento che si potrebbe definire, richiamando in servizio un termine ormai desueto, ma sempre efficace, della “sprezzatura”, come testimonia la chiusa:
“I libri di ricordi e di memorie rischiano sempre di debordare e se lo facessi sarei in contraddizione con il me stesso, autore di aforismi. Così ho deciso di concludere queste pagine di vita vissuta fra il teatro, la televisione, la scrittura, il giornalismo, l’arte e l’università. Kierkegaard ha scritto una grande verità: “ La passione è l’elemento essenziale, l’autentico dinamo degli uomini”.
[1] A suo tempo fu accusato di aver aiutato Eatherly, uno dei due piloti che sganciò la Bomba su Hiroshima, a fuggire dal manicomio dove era stato rinchiuso, essendosi dichiarato colpevole dell’atto compiuto, anche se per ordini superiori ai quali non avrebbe potuto disubbidire, e per tale ragione considerato insano di mente. Sul loro carteggio – importante la tesi del filosofo che sosteneva che Eatherly non poteva in alcun modo essere perdonato del crimine, sia pure comandato, e solo accettando tale dato di fatto dimostrava di essere sano – usci un coinvolgente volume, pubblicato in Italia da Einaudi nel 1962 col titolo La coscienza al bando.
[2] L’ultimo numero (il 33°) della rivista della Società italiana di psicoanalisi lacaniana, “attualità Lacaniana”, diretta ora da Fabio Galimberti, dedicato al tema dell’Apertura, ospita anche un mio contributo dal titolo “La dannazione dell’incipit e il sipario come oggetto-simbolo”-



